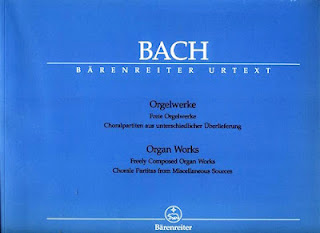Stasera sono andata a vedere un film inusuale, un'opera prima, che merita un posto in questo blog perché ha a che fare con la musica. Il film è intitolato "Quartet" ed è diretto da Dustin Hoffman. Ha una trama molto semplice ed oserei dire leggera (una grande ex-cantante è costretta a trasferirsi in una casa di riposo per musicisti e qui re-incontra il suo ex-marito), ma il cast di tutto rispetto (tra cui una superba Maggie Smith), la delicatezza della regia nel trattare l'anzianità e le fulminanti battute britanniche rendono il film davvero godibile.
La musica, di repertorio (Verdi, Boccherini, Bach-Busoni, Haydn, etc.) ma anche abilmente "manipolata" dall'italianissimo Dario Marianelli, aveva una ruolo non indifferente nel film. La sorpresa è stata scoprire al termine che gli interpreti della maggior parte dei brani erano gli attori stessi della pellicola, veri ex-artisti e solo prestati al cinema. Ovviamente tranne i quattro protagonisti del quartetto vocale del titolo (dal Rigoletto, in un'edizione con Pavarotti e la Sutherland) che sono, invece, navigati attori professionisti, ma presumibilmente non musicisti per cui non vengono mai ripresi a scimmiottare le movenze di un cantante.
Da segnalare le scene in cui l'opera viene descritta e paragonata al rap in un improbabile seminario per ragazzini. L'unico neo, se proprio bisogna trovarne, è stato aver scelto un'opera lirica che non ha alcuna relazione con la vicenda dei protagonisti. Nel complesso, credo sia un modo piacevole per trascorrere una serata, rivalutando l'esperienza e l'entusiasmo degli anziani senza ipocrisie o depressioni e recuperando brani musicali celebri in arrangiamenti nuovi. E per chi non sapesse cosa sia Casa Verdi, in qualche modo l'ispirazione per questo film, ecco il link.